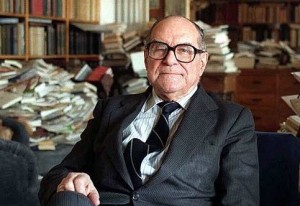Essere genitori: figli, sesso e cattiva educazione
Elisabetta Bagli è una poetessa molto impegnata nel trasmettere ai propri lettori le sensazioni che derivano dalle ingiustizie umane. Sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne, dei bambini e delle persone più deboli, tesse nella propria poetica i drammi quotidiani che spesso sfociano in tragedie. La sua sensibilità, tutta femminile, ne ha fatto il portavoce ideale, la Penna in grado di non far mai dimenticare quello che accade intorno a noi, anche quando i nostri occhi sono troppo stanchi per vedere. Nell’articolo che segue, espone un classico esempio di cattiva educazione, da parte delle istituzioni, nei confronti dei minori in età scolare.
Elisabetta Bagli ha pubblicato con EEE: Voce

Il non facile compito di Educare
Di Elisabetta Bagli
Le polemiche che si sono innalzate in questi giorni, in Spagna, su un evento increscioso di cui sono stati protagonisti un ex Ministro del Governo catalano, Marina Geli, e il giornalista Eduardo García Serrano mi hanno fatto riflettere (e non poco) sul mondo in cui viviamo.

Marina Geli
Non voglio assolutamente entrare nel merito politico della questione, che non è di mia competenza, ma sono stata fermata davanti alla Scuola, che frequentano i miei figli, da Intereconomia (testata giornalistica) che mi ha intervistato sull’argomento trattato in un video (per fortuna non più disponibile in rete NdR), proposto dal Ministro, in merito all’educazione sessuale per i minori nelle scuole. Mi è stato chiesto cosa ne pensassi e se ritenessi tale video idoneo per essere mostrato ai ragazzi in età scolare. Nel filmato si vede un ragazzo che fa ogni tipo di esperienza sessuale sia con i suoi coetanei e le sue coetanee sia con uomini più grandi. Alcune immagini istigano addirittura al bondage e al sadomasochismo. La seconda parte del video, invece, è incentrata su una ragazza che, per autodeterminazione, sceglie, “provando” i vari partners attraverso esperienze anche estreme, qual è l’uomo della sua vita. Non sono una bigotta, ma sono una madre di due bimbi di 9 e 12 anni e non credo che questo sia il modo adeguato per affrontare l’argomento “educazione sessuale” nelle scuole e sulle pagine istituzionali di siti governativi. Il video in questione era stato inserito nella pagina Sexo Joven de la Generalitat de Catalunya dall’allora Consigliere della regione Marina Geli, affinché fosse una sorta di manuale per i ragazzi.

Eduardo García Serrano
Un giornalista, Eduardo García Serrano, ha denunciato questa pagina ritenendola offensiva e istigatrice per la nostra gioventù, insultando con parole dure il Ministro. Per questa sua rimostranza, lo Stato spagnolo l’ha condannato a dover pagare 22.000 Euro, mentre al Ministro è stato solo fatto ritirare il video dalla pagina.
Ripeto, non entro nel merito della condanna o della questione politica. Ma sono una mamma che tiene all’educazione dei suoi figli, come tante mamme in questo mondo e non credo che sia necessario proporre video di questo genere a dei bimbi o a degli adolescenti né nelle scuole né, tanto meno, sui siti istituzionali per impartire l’educazione sessuale ai nostri figli. È vero che la gioventù di oggi è diversa da quella di un tempo. È vero che a 12 anni io ancora giocavo con la Barbie e cercavo di fumare la prima sigaretta, come atto d’insubordinazione (ringrazio il cielo che mi ha stomacato appena messa in bocca, aiutandomi a stroncare il “vizio” sul nascere), mentre mia figlia, a poco meno di 12 anni, già sa molte cose della vita, del suo corpo, di ciò che le gira intorno e ha desideri diversi di quelli che avevo io alla sua età. È vero che i ragazzi di oggi sono più svegli e svelti a fare tutto, ma è anche vero che, pur credendo di avere il mondo in mano e di sapere tutto, pur pensando di essere i migliori e invincibili, non riescono, nel loro intimo, a essere sicuri di se stessi e sono molto più fragili di quel che mostrano. Hanno in mano molta informazione della quale spesso non sanno cosa farsene, come utilizzarla. Hanno voglia di sfidare il mondo, perché si credono invulnerabili, ma non pensano che spesso le prime vittime di questi loro atteggiamenti sono proprio. Gli atti di bullismo che ci sono per ogni dove, quelli di violenza ai propri simili, non solo fisica ma anche verbale, quegli atti di insubordinazione nei quali mancano di rispetto non solo ai genitori ma anche agli insegnanti e a tutto ciò che rappresenta la disciplina, sono ormai all’ordine del giorno.
Noi genitori ci siamo mai chiesti il perché di tutto questo? Mancano le linee guida, quei tre cardini fondamentali che sono stati il sostentamento delle generazioni da sempre: i genitori, la scuola, la società.
I genitori sono troppo occupati a cercare di fare bene i genitori moderni dalla mentalità aperta, dai sorrisi “smart”, senza comprendere che è necessario essere veramente genitori per educare i figli: non si deve essere fratelli, zii o amici, ma genitori!

Mom serie tv
Giorni fa mi sono imbattuta in una nuova serie televisiva che fanno vedere qui in Spagna da poco tempo, il titolo è “Mom”. Il limite minimo di età per vederla è di 12 anni! Sono rimasta allibita! Mia figlia e mio figlio avevano iniziato a vedere questa serie nella quale si parla di sesso, anche spinto, di alcool e di famiglie allargatissime. Ci sono delle donne che passano da un uomo a un altro in modo superficiale e che rimangono incinte di sconosciuti come se fosse la cosa più normale di questo mondo! Comprendo l’intento degli sceneggiatori di far ridere su argomenti che sono seri e che, quindi, molto dietro le righe, dovrebbero fare comunque riflettere, ma i bimbi di 12 anni non sono in grado di capirlo e il messaggio che passa è deleterio! Non hanno coscienza critica! Figuriamoci poi se hanno coscienza critica i bimbi di 9 come mio figlio! Ho proibito ai miei figli di vedere questa serie e loro, logicamente, si sono alterati, soprattutto mia figlia Francesca che mi ha detto: “Ma mamma, è proibito ai minori di 12 anni e io ne quasi 12! Dai!”
Chi decide il limite d’età? Che valori si prendono come termini di paragone per decidere questi limiti? Non comprendo… Ma poi penso al fatto che mia figlia tornerà a scuola, che i suoi compagni inizieranno a commentare “Mom” e che lei si sentirà esclusa, si sentirà una “mosca bianca” per non averlo visto, per non avere il cellulare, per non fare o dire o avere altre mille cose che i genitori “amici”, nella loro visione “moderna”, fanno, dicono o danno ai propri figli in un’età non consona. Non sono una mamma speciale, anzi sono normalissima, con i miei pregi e i miei difetti, come tutte le mamme che stanno imparando a crescere i propri figli, ma so che come me la pensano altre milioni di mamme e spesso, per quieto vivere, lasciano correre e lasciano che i figli facciano quel che credono, perché è più facile dire SÌ che dire NO.
Cos’altro manca a questi ragazzi? La scuola, intesa come docenti e non come struttura, perché badate bene che i mezzi e le strutture per fare bene ci sono, ma sono mal utilizzate. Ora, la maggior parte dei docenti sono votati a prendere lo stipendio a fine mese e basta. Sono realmente pochi coloro che si preoccupano di fare gli “educatori” nel vero senso della parola. E la scuola è formazione, è educazione, è trasmissione di messaggi giusti, di valori, al pari della famiglia. Ma oggi, è troppo spesso latitante.
L’ultimo punto cardine che manca ai ragazzi è la società. Nonostante ci siano strutture adeguate per sostenere i giovani, inadeguati sono spesso i modi con le quali vengono usate. Oggi la società è volta a insegnare il modello di vita del “tutto e subito”, perché solo ottenendo tutto e subito si può dire di aver vissuto davvero intensamente. Questo è il messaggio che viene dato ai ragazzi e non c’è nulla di più errato! Il modello del “tutto e subito” al giorno d’oggi viene applicato in ogni campo, anche nell’educazione sessuale proposta nel video, di cui vi ho parlato all’inizio, che prevede due giovani, un uomo e una donna, che per vivere in pieno la loro sessualità devono provare ogni tipo di esperienza, anche la più aberrante. Ma se ai ragazzi non vengono spiegate prima altre cose, quali l’amore, il desiderio, la vita, il piacere di condivisione con l’altro sesso, cosa potranno mai comprendere di quel che viene loro mostrato nel video? Nulla! Possono pensare solo che è quello il modo giusto di amare.
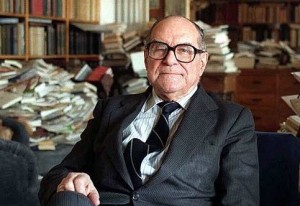
Julian Marias
Ma bisogna ricordarsi che affinché ci possa essere una buona educazione sessuale ci deve essere un’ottima “educazione sentimentale”, così come ci diceva il filosofo Julián Marías nel suo famoso libro “La educación sentimental”.
Ma l’educazione sentimentale, a cui ogni società dovrebbe far riferimento, è ormai uno strumento educativo e formativo troppo obsoleto e lento per l’uomo di oggi. Si dovrebbe dedicare molto tempo a educare l’essere umano e l’uomo ormai non ha più tempo neanche per se stesso. Credo che si sia persa la bussola e che ciò che “normale non è” sia diventato la “normalità”, degradando il modello educativo personale e sociale, facendolo arrivare a uno tra i livelli più bassi della storia. Cosa fare, quindi?
Rimboccarsi le maniche. Ognuno di noi, nel suo piccolo, deve cercare di fermarsi e prendersi il tempo giusto per educare ed educarsi. Le esperienze vanno vissute e ogni persona è libera di scegliersi quelle che vuole provare e il modo in cui lo vuole fare, ma tutto deve avvenire a tempo debito, con coscienza e consapevolezza, cosa che i giovani di oggi credono di possedere e, purtroppo, non hanno.
È compito nostro, genitori, educatori e società, prendere in mano la situazione e cercare di capovolgerla perché non dobbiamo dimenticarci che l’oceano è formato da tante gocce e ogni piccola goccia può aiutare a ingrandire il mare.
 La poesia è anima che scrive
La poesia è anima che scrive Io scrivo di ciò che mi circonda immaginando di camminare su una corda sottile fatta di parole. Scrivo di estremi, di vertici, di angoli bui e ombrosi, di fragilità, di limiti. A volte temo che la corda si spezzi e invece, come per magia, ogni giorno diventa sempre più robusta.
Io scrivo di ciò che mi circonda immaginando di camminare su una corda sottile fatta di parole. Scrivo di estremi, di vertici, di angoli bui e ombrosi, di fragilità, di limiti. A volte temo che la corda si spezzi e invece, come per magia, ogni giorno diventa sempre più robusta.
 Andrea Leonelli e il valore terapeutico della scrittura
Andrea Leonelli e il valore terapeutico della scrittura